Nel gennaio 1924, Vittorio Bonadé Bottino – un ingegnere torinese che doveva diventare il principale artefice dell’architettura industriale della Fiat – ebbe il suo primo incontro professionale con Giovanni Agnelli, da cui sarebbe dipeso il suo futuro lavorativo. Avvertito una sera che l’indomani mattina alle otto ci sarebbe stato l’incontro col Senatore, Bonadé Bottino confesserà di essere stato turbato dalla convocazione, al punto di essersi preparato all’appuntamento con una passeggiata “dalle sette e mezza alle otto di una fredda e nebbiosa mattina […] lungo il viale dei tigli del Valentino”. L’ancor giovane ingegnere, quasi trentacinquenne, con una notevole esperienza professionale e reduce dalle trincee della prima guerra mondiale, subì in pieno la soggezione che emanava dalla figura del Senatore, il quale – a meno di sessant’anni d’età – era già circonfuso da un alone di fama e di distacco che lo rendeva diverso da tutti gli altri rappresentanti del mondo imprenditoriale.
A Bonadé Bottino rimarranno impressi nella memoria “il viso severo e lo sguardo scrutatore” di Agnelli, che rivelavano in lui “una indomita volontà, tesa da molti anni a realizzazioni concrete di vasta portata”, segno di un’indole che “aveva sovrapposto a un volto dall’espressione abbastanza benevola nei momenti di distensione una maschera dall’espressione dura con la quale affrontava i dipendenti”.
Questo è uno dei tanti ritratti che si ripetono e si aggiungono, convergendo e confondendosi nel profilo del grande imprenditore. Un tipo ideale che il Senatore – così lo citano tutti coloro che gli si riferiscono – incarna negli anni Venti in Italia, riassumendo nella sua identità i tratti associati alla leadership industriale. Nell’élite economica di Torino e dell’Italia la sua posizione è speciale: nessuno ne mette in dubbio il rilievo e anche l’eccezionalità. Il Senatore è unico, un po’ come la sua creatura, la Fiat, un’impresa che svetta sulle altre. La sua dovrebbe essere anche una condizione di isolamento, nella cornice di un paese, l’Italia, che è ancora lungi dall’essere industriale, ma non è così perché tutti gli riconoscono il carattere e il carisma del leader.
Quando il Senatore si è conquistato sul campo un simile prestigio pubblico, se le sue abitudini di vita lo tengono distante dal contatto con gli altri? Quando l’imprenditore Giovanni Agnelli, il brillante ex ufficiale di cavalleria che s’incontrava con gli amici interessati al nuovo mondo dell’automobile nelle sale del Caffè Burello, è diventato “il Senatore”, quella personalità che suscita un rispetto reverenziale?

Lo era divenuto prestissimo, ben prima che nel 1923 gli venisse attribuito il laticlavio senatoriale. A determinare il salto di qualità era stata la sua visione di innovatore, che si era rivelata in pieno ancor prima della Grande guerra, negli anni Dieci.
L’avevano inteso subito i più acuti protagonisti del sistema delle imprese d’allora. Come il fondatore e il primo presidente della Lega Industriale di Torino, nonché presidente della Confederazione dell’Industria Italiana, il francese Louis Bonnefon-Craponne, che aveva incontrato Agnelli nelle officine Fiat di corso Dante, al ritorno da un viaggio negli Stati Uniti, poco prima della guerra. Bonnefon-Craponne ne avrebbe riferito soltanto più tardi, nel suo libro L’Italie au travail (1916), una sorta di reportage sull’Italia industriale che stava ormai acquistando consistenza e importanza.
Nel racconto del presidente degli imprenditori, la visita alla Fiat costituisce l’occasione per cogliere i tratti portanti del futuro dell’industria. In un ambiente che appare già conquistato ai valori di “modernità e scientificità organizzativa”, dove imperano i tre elementi dell’ordine, dello spazio e della luce, egli intervista Agnelli con l’occhio rivolto “al lato opposto del corso”, in cui “un’immensa costruzione in cemento armato innalza i suoi tre piani nel cielo azzurro”: è il “nuovo colossale reparto della grande fabbrica, che cerca di lottare contro la crisi e la concorrenza imponendosi con la perfezione delle sue macchine”.
“Torno ora dall’America”, è il fondatore della Fiat a parlare, “dove ho voluto personalmente rendermi conto del pericolo che minaccia non solo l’industria italiana, ma anche quella francese e tedesca”. Il problema è costituito dalla concorrenza degli Stati Uniti, sempre più agguerrita, che rischia di acuire il divario di produttività tra le due sponde dell’Atlantico.
“Alla Fiat”, spiega Agnelli al suo interlocutore, “produciamo ogni anno dalle tre alle quattromila macchine, mentre alla Studebaker o alla Ford ne fabbricano da 150 a 200.000!” Automobili che richiedono “un lavoro meno rifinito, meno accurato”, non paragonabile a quello che si svolge alla Fiat, gli obietta il suo interlocutore. Pronta la replica di Agnelli: “Naturalmente sono macchine fatte in serie. La nostra clientela non è ancora abituata ad accontentarsi di vetture che non possono reggere un uso prolungato; per di più, esige che anche i pezzi più piccoli siano lucidati e nichelati. Quando si tratta delle nostre macchine, anche i minimi dettagli, non solo della carrozzeria, ma anche del motore o degli accessori, devono essere perfetti”. Ma basta questa cura estrema della qualità per permettere all’industria europea di scampare alla sfida di quella americana? Agnelli ne dubita: “Forse”, dice, essa “si vedrà presto costretta a limitare la propria clientela alle persone che vogliono esibire il lusso”, ma “si tratta di un mercato ristretto, che non basterebbe più a una produzione organizzata sulle basi della nostra”.
A questo punto Bonnefon-Craponne solleva la domanda cruciale: “Non si potrebbero introdurre in Europa i sistemi di fabbricazione americani?” In altri termini, l’alternativa sta nell’adozione del metodo della mass production, nei princìpi organizzativi di Taylor e di Ford? Ma “Agnelli evita di rispondere. Nei suoi occhi passa un lampo, subito offuscato, e il suo viso […] rimane impassibile”.
La risposta di Agnelli va cercata non nelle sue dichiarazioni pubbliche, ma in un documento aziendale importante come i verbali del consiglio di amministrazione della Fiat. Vi si legge alla data del 2 giugno 1915, poco più di una settimana dopo l’entrata in guerra dell’Italia: “Un nuovo grandioso stabilimento è l’unico mezzo per poter fronteggiare la concorrenza interna ed estera, permettendo la riduzione dei prezzi, cosa possibile soltanto con una aumentata produzione e con uno stabilimento modello […]”.
È l’annuncio del programma produttivo che culminerà, nei primi anni Venti, con la costruzione dello stabilimento del Lingotto, all’epoca il più grande impianto automobilistico d’Europa.
A distinguere il Senatore dagli altri imprenditori italiani del suo tempo e a guadagnargli una particolare aura di rispetto e di prestigio è la sua visione industriale, insieme con la determinazione che impiega nel perseguire obiettivi che ritiene indispensabili. Come, in primo luogo, quello di trapiantare nelle sue fabbriche il modello della produzione di massa, uno scopo verso cui indirizzerà progressivamente tutte le energie della Fiat. Per lui davvero quella dell’automobile rappresenta “l’industria delle industrie”, secondo la celebre definizione che Peter Drucker conierà negli anni Quaranta, il settore da cui dipende la crescita economica di una nazione.
Agnelli vuole strappare il sistema dell’auto al circolo vizioso di cui sarà vittima ancora nel periodo fra le due guerre mondiali: se non aumenta il numero dei consumatori e il mercato permane angusto, i prezzi delle vetture restano inevitabilmente elevati, troppo perché possa aumentare il pubblico degli acquirenti. Per Agnelli “il problema della standardizzazione è insito nello sviluppo dell’automobilismo”, come sta scritto in uno studio sulle prospettive del mercato dell’auto del 1930. Ecco perché devono cambiare sia l’approccio dei costruttori sia la mentalità dei consumatori, in modo da concepire l’auto non più come un bene di lusso, bensì come un mezzo di lavoro per gli “affari giornalieri”.
Non si può comprendere la storia della Fiat nei decenni in cui fu guidata dal Senatore, se non si tiene presente l’obiettivo di fondo che era la sua stessa stella polare, cioè la ricerca delle condizioni tecnologiche, organizzative e di mercato che potevano condurre a creare la versione italiana del modello americano della mass production. Lo testimonia con chiarezza Dante Giacosa, il progettista delle piccole vetture di successo (la Topolino, la 600, la 500), attraverso la sua lunga carriera professionale.
Tutto ha inizio da quel mattino di fine inverno del 1933 quando l’ingegner Antonio Fessia chiamò Giacosa nel suo ufficio, all’ultimo piano della palazzina del Lingotto, per dirgli che il Senatore voleva che si progettasse “una vettura piccola, economica”, da vendersi al prezzo più contenuto possibile. Se la sentiva di disegnare châssis e motore?

Il giovane ingegnere, appena ventottenne, rispose con entusiasmo a quella sfida. Anche il suo capo, che non aveva molti anni più di lui, dovette avvertire l’impegno della sollecitazione che era venuta da Agnelli, ma l’aveva accolta con maggiore freddezza, non foss’altro perché sapeva di giocare su di essa il proprio futuro e aveva una posizione rilevante da difendere. Giacosa invece intuì che quella era la sua grande occasione, anche se confesserà nelle sue memorie di non aver mai saputo “in seguito a quali considerazioni il senatore Agnelli avesse deciso di affidare” al suo ufficio quell’incarico così delicato, che comportava “la responsabilità di dirigere il progetto della piccola vettura utilitaria con la quale intendeva far compiere alla Fiat un nuovo decisivo balzo verso la produzione di massa”. Questo restava il fine autentico verso il quale Agnelli mobilitava le energie migliori dell’azienda, pur nel momento più acuto della grande crisi degli anni Trenta.
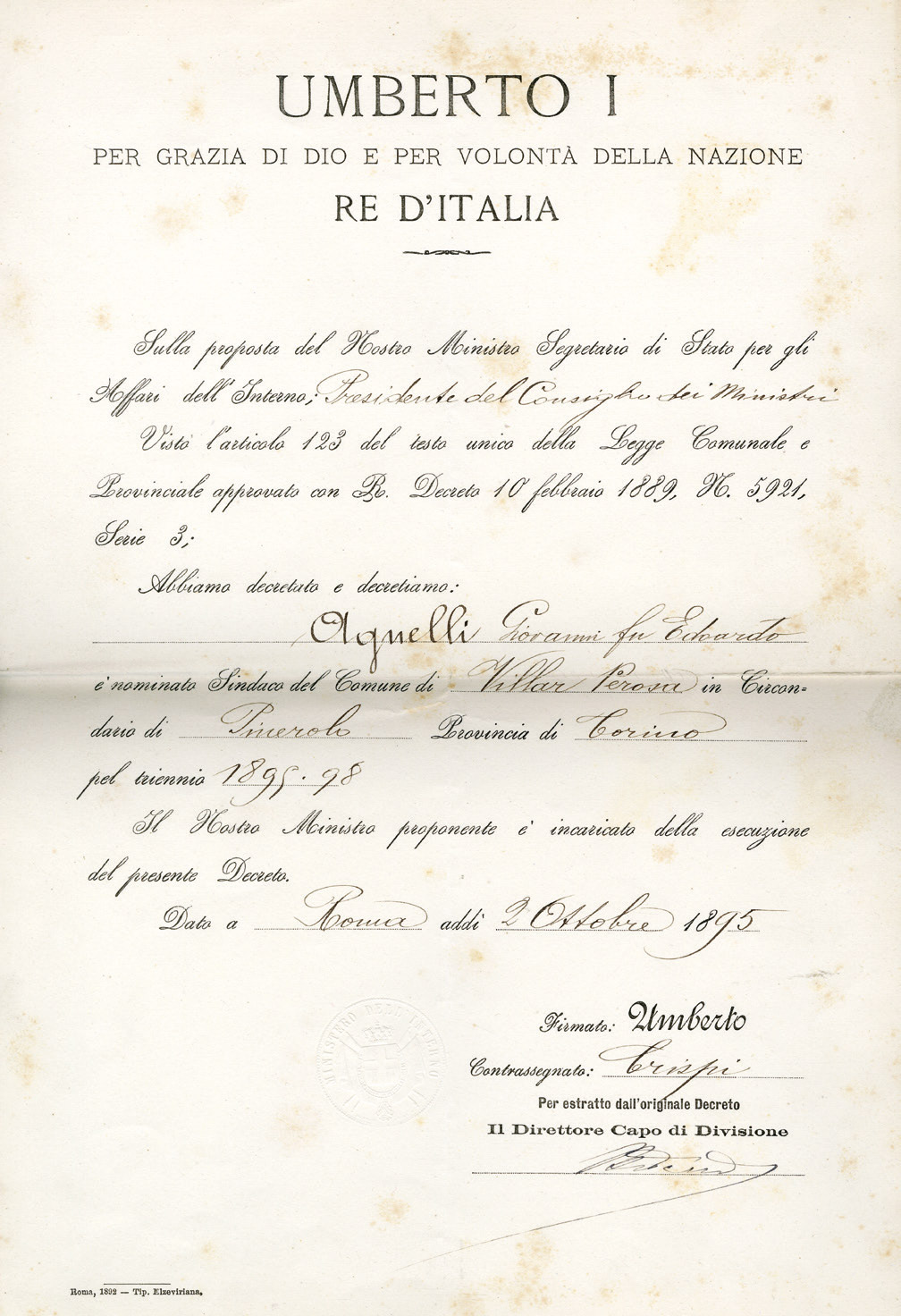
Il conferimento da parte del Politecnico di Torino della laurea honoris causa in ingegneria al Senatore, nel febbraio 1937 (dunque a poco più di sei mesi dal lancio della Topolino), venne a riconoscimento di questo sforzo. Nel giugno successivo, per celebrare l’evento, gli ingegneri di “tutto il Gruppo Fiat” e della RIV di Villar Perosa, “vicini e lontani sparsi in ogni parte del mondo”, gli offrirono un album coi disegni di quattordici artisti fra i più significativi del tempo come Felice Casorati, Carlo Carrà, Francesco Menzio. La presentazione dell’omaggio toccò al progettista in possesso della più lunga anzianità aziendale, cioè Celestino Rosatelli, l’ideatore di tanti velivoli delle serie br e cr, in forza alla Fiat dal 1918. Rosatelli parlava a nome dei trecento ingegneri che contava l’azienda (su un totale di oltre 50.000 dipendenti, 6600 dei quali impiegati e dirigenti).
Agnelli ringraziò per le sue parole Rosatelli, un uomo – sottolineò – “a cui la Fiat [doveva] talune delle sue più importanti affermazioni in campo aeronautico”, che lo rendevano “ben degno di rappresentare, con la sua genialità, non superata che dalla personale modestia, il valore di tutti i nostri ingegneri, di tutti i nostri tecnici, con la laurea o senza”.
Quest’espressione – “con la laurea o senza” – non suona casuale, perché il Senatore voleva mettere in rilievo come il riconoscimento del Politecnico fosse destinato alla Fiat, “formatrice di valori tecnici”, “vivaio di energie costruttive”, “scuola di esperienza, da cui tanti giovani, dotati e volenterosi si [erano] lanciati e si lancia[vano] per accrescere, spesso con realizzazioni di primato, il patrimonio d’invenzioni e di applicazioni dell’Ingegneria italiana”. Insomma, Agnelli, “laureato da quattro mesi, pur essendo alla Fiat dal 1899” aveva cura di far notare come “la laurea, nobile titolo di studi compiuti, di scienza appresa nelle scuole”, non fosse che “un punto di partenza”. Poi si trattava, “specie nel campo tecnico, di laurearsi al banco di prova dell’esperienza, lavorando nel laboratorio e nell’officina”.
Così il Senatore intendeva segnalare il primato della cultura della produzione. Essa veniva forgiata in fabbrica giorno dopo giorno, grazie alla confluenza del sapere dei tecnologi e di quello impastato dalla sperimentazione pratica e quotidiana di tanti operatori aziendali, che coi progettisti dovevano necessariamente collaborare. Quindi Agnelli esaltava sì le realizzazioni dei suoi progettisti, valorizzando l’opera di un artefice dell’aviazione italiana come Rosatelli, ma nel medesimo tempo badava a ricordare che la mass production non era soltanto frutto della progettazione a tavolino, ma anche dell’esperienza di fabbrica, che contribuiva a introdurre continui miglioramenti nei processi produttivi e nei prodotti.
Il Senatore badava peraltro a intrattenere un rapporto privilegiato con i progettisti, con coloro che mettevano a punto i prototipi di auto e di aerei che poi avrebbero portato direttamente alla sua valutazione. Questo spiega il legame speciale che lo unì a loro, sebbene non sarebbe mai sfociato in una sorta di predominio delle funzioni progettuali all’interno del sistema aziendale. L’universo tecnico era fondamentale, ma non doveva minare la supremazia della sfera delle decisioni strategiche d’impresa, che atteneva alla complessità della gestione aziendale e non poteva essere subordinata a logiche parziali. Di qui il duplice registro che contraddistingueva la frequentazione del Senatore con gli ingegneri e i gruppi di progettazione.
Per un verso, era incline ad accordare loro un’attenzione tanto accentuata da stupire persino gli interessati. Per esempio, Giuseppe Gabrielli – il nome più famoso e reputato dell’aviazione Fiat, il personaggio chiave della sua storia – ricorderà nelle sue memorie i numerosi incontri informali con il Senatore, nel corso degli anni Trenta: “Spesso invitava a cena a casa sua Rosatelli e me e, dopo che sua moglie, Donna Clara, si era ritirata, rimaneva per ore a sentirci parlare di aeroplani, di ali, di strutture. Talvolta si faceva accompagnare da noi in qualche teatro di varietà, dove finivamo la serata allegramente”.
Per un altro verso, la storia della Fiat è punteggiata, fin dai suoi primi anni, dai contrasti fra Agnelli e i progettisti, come quello che fu all’origine della rottura con Aristide Faccioli, il primo direttore tecnico, che se ne era allontanato già nel 1901. Ma anche col suo successore, l’ingegnere Giovanni Enrico, i rapporti non erano stati piani. Agnelli non aveva mai rinunciato ad avere l’ultima parola sulle scelte tecniche, convinto com’era che questa dovesse essere la prerogativa indispensabile dell’imprenditore.
La vita e l’attività degli ingegneri alla Fiat non dovettero essere mai troppo facili, se stiamo al racconto contenuto nelle belle pagine autobiografiche dell’altro progettista per eccellenza, Giacosa. Questi descrive un mondo tecnico aziendale attraversato dalle rivalità personali e di gruppo e anche dai conflitti fra gli ingegneri: confronti tra personalità, approcci e idee da cui scaturiva l’evoluzione tecnologica della Fiat. Una realtà solcata dalla competizione tra le persone oltre che tra le funzioni, sulla quale imperava, con autorità assoluta e calma inattaccabile, il decisore di ultima istanza, cioè il Senatore. Il quale, come si è visto, era disposto a dedicare gran tempo ai suoi tecnici.
Li riceveva – racconta Giacosa – nel suo ufficio dal tavolo “perfettamente sgombro: non un foglio; non una lettera; c’era solo una matita copiativa con la quale firmava le poche lettere che il suo segretario, dottor Canova, gli portava con molta discrezione”. Gabrielli assisteva sovente a questa “cerimonia”, come la chiama, quando nel tardo pomeriggio il Senatore lo convocava “per parlare di aviazione”. Prosegue Gabrielli: “Io temevo di fargli perdere ore preziose e un giorno gli dissi: ‘Ma come fa, Senatore, con tutto il lavoro che ha, a trovare il tempo per queste conversazioni?’, mi rispose: ‘Lavoro? Io non lavoro, penso solo a quello che devono fare gli altri’”.
Il capo d’impresa appariva ai progettisti come un demiurgo, che mostrava di sovrintendere ai compiti degli staff tecnici con una dedizione assidua quanto imperturbabile. Faceva mostra di comprendere i problemi di cui gli parlavano, ma con una diversa intelligenza delle cose: il suo sguardo restava comunque inassimilabile al loro, poiché collocava i loro progetti in una diversa prospettiva, in un campo di un’ampiezza tale da essere precluso agli altri.

Poteva ascoltare gli ingegneri discutere per ore e sentirli confrontarsi tra di loro senza che ne venisse influenzato il suo giudizio finale, basato su elementi di valutazione e di visione che controllava lui solo. E tuttavia non mancava di esibire, nelle occasioni giuste, anche un senso di riconoscenza per la perizia tecnica spesa a vantaggio dell’azienda. Otto anni dopo l’episodio della laurea honoris causa, Agnelli ebbe modo di ricambiare in maniera concreta l’omaggio di Rosatelli. Questi morì sessantenne nel settembre del 1945. Il Senatore, anch’egli verso la fine della propria esistenza – si spegnerà a Torino il 16 dicembre dello stesso anno –, si fece accompagnare da Gabrielli, nella Torino ancora un po’ spettrale dell’immediato dopoguerra, all’abitazione dello scomparso, in un edificio il cui ascensore non funzionava. Così, sostenuto da Gabrielli, salì lentamente tre piani di scale. Poi, “volle baciare la salma, disse alcune parole di conforto ai familiari e uscì.” La sua era la testimonianza estrema di un patto di collaborazione che si era sviluppato nei decenni alla Fiat.
Nel periodo fra le due guerre, la Fiat disponeva di una ridotta compagine direzionale, imperniata sulla figura del Senatore, progressivamente affiancata da Vittorio Valletta. Agnelli, interessato a ogni dettaglio, era l’interlocutore determinante dei progettisti, colui che li incalzava – ma al contempo li sosteneva – nel loro lavoro, che li poneva incessantemente alla prova partecipando alla presentazione dei loro prototipi, dei quali era il giudice ultimo.
Gabrielli si sofferma sul clima di trepidazione incombente ogni volta che il Senatore saliva su un aereo per un volo di prova. Nel campo aeronautico, come in quello automobilistico, quelle uscite vedevano un altro protagonista, oltre al leader della Fiat e ai progettisti: il pilota collaudatore, che ricopriva un ruolo fondamentale nel rivelare pregi e difetti di un nuovo prodotto, come nell’indicare i correttivi da applicarsi. Stava poi ancora all’abilità dei progettisti riuscire a riformulare quei rilievi secondo adeguati parametri tecnici.
Era un vero e proprio rituale, centrale entro la simbologia della vita aziendale, per il suo carattere di momento essenziale di verifica, ma altresì importante per quello stretto rapporto dei progettisti col Senatore, che riscattava la subalternità gerarchica dei primi ai responsabili della produzione. Al punto che il giovane Giacosa aveva imparato a valutare la carriera e la fortuna professionale dei suoi capi, a cominciare dall’ingegner Fessia, dalla regolarità con cui costoro, verso le cinque del pomeriggio, si recavano nell’ufficio del Senatore.
Quell’atmosfera competitiva in cui erano immersi gli uffici tecnici della Fiat, regolata dall’autorità di Agnelli, non era iscritta nel codice genetico dell’azienda. Era piuttosto, almeno in parte, il frutto di un disegno strategico, dettato dalle particolari condizioni di mercato e volto a stimolare la concorrenza tra le funzioni operative in modo che esprimessero il meglio di cui erano capaci.
Anche questa tensione impressa al sistema aziendale era connessa al traguardo che Agnelli aveva in mente fin dai suoi viaggi americani d’inizio secolo: la Fiat e l’industria europea dovevano assimilare la lezione americana e assumere come obiettivo la produzione di massa. Era a questo punto d’arrivo che il Senatore, attraverso una catena incrementale di innovazioni, intendeva condurre la sua impresa. Varcare questa soglia voleva dire imprimere a tutta la Fiat un impulso tale da sottrarla alle angustie e alle rigidità del passato. L’intera azienda avrebbe allora beneficiato di una logica unitaria, pervasiva, in grado di ricomporre l’opera delle diverse funzioni organizzative, mobilitando e promuovendo tutte le loro energie.
Per trent’anni la leadership di Giovanni Agnelli si misurò con questa strategia, approdando nel giugno 1936 (“una data memorabile per la Fiat”, secondo Giacosa) all’avvio della “produzione in grande serie per la quale in definitiva era stato costruito lo stabilimento del Lingotto”: allora “il ritmo di produzione raggiunse rapidamente le 100 vetture giornaliere”, rammenterà ancora Giacosa, con una nota di fierezza per il successo della sua Topolino. Certo, permaneva un consistente divario di produttività con l’industria americana, ma i tecnici della Fiat erano persuasi di avere finalmente imboccato la strada buona per dare vita a un mix riuscito di prodotti e tecnologie orientati al mercato di massa.
La seconda guerra mondiale e le sue conseguenze avrebbero imposto una prolungata battuta d’arresto a quei piani di espansione. Non di meno, quel periodo di incubazione guidato dal Senatore, quella stagione febbrile di preparazione, costituiscono la piattaforma su cui potrà esplicarsi, negli anni Cinquanta e Sessanta, il pieno dispiegamento delle capacità tecnologiche, produttive e organizzative della Fiat.
Giuseppe Berta